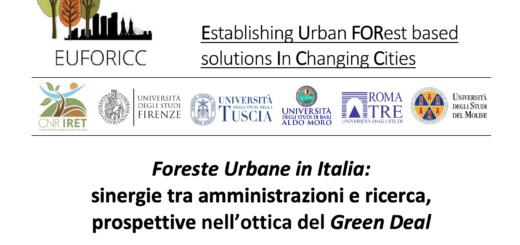Gli effetti dell’aumento di CO2 sugli ecosistemi terrestri: cosa sappiamo e cosa ancora c’è da capire?
Dalla rivoluzione industriale ad oggi le attività antropiche hanno aumentato la concentrazione atmosferica di CO2 del 48%. Qual è l’impatto di queste grandi quantità di CO2 sugli ecosistemi? Un recente studio, che ha coinvolto più di 60 scienziati provenienti da tutto il mondo, ha provato a fare ordine tra le ricerche svolte fino ad oggi. la review conferma che l’aumento della CO2 in atmosfera ha un evidente effetto fertilizzante su molte foreste. Allo stesso tempo però, emerge che le nostre conoscenze non sono esaustive circa la quantificazione di questi aumenti e che il ruolo giocato da altri fattori esterni all’aumento di CO2, quali temperatura e nutrienti, non è ben definito.