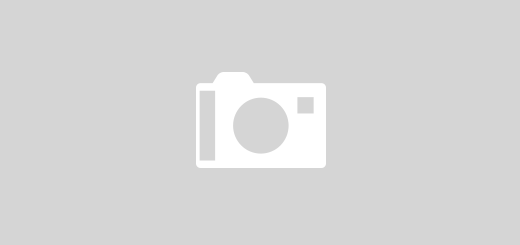15 studi forestali del 2025, scelti e raccontati da SISEF – Parte 2

Se ti sei perso il primo episodio clicca qui
Quando parliamo di “soluzioni forestali” al cambiamento climatico, spesso immaginiamo due
gesti semplici: piantare alberi e usare più legno. Nel 2025, però, tre studi hanno rimesso al
centro una domanda meno comoda e molto più concreta: cosa succede davvero al bilancio del
carbonio quando tagliamo, trasformiamo e consumiamo legno, e quando la nostra domanda di
prodotti (agricoli e forestali) sposta la deforestazione altrove?
Questo secondo post di SISEF sui quindici studi forestali più interessanti del 2025 mette
insieme un dibattito scientifico su come stimare le emissioni legate alla gestione forestale;
uno studio che prova a quantificare se le “città in legno” sono fisicamente e industrialmente
fattibili senza aumentare i tagli; e una revisione che mostra come oggi si misura l’impronta di
deforestazione importata, cioè chi “consuma” deforestazione internazionale anche se non la
vede nei propri confini nazionali.
1) Global wood harvest is sufficient for climate-friendly transitions to timber cities
(Yayla et al., Nature Sustainability)
L’idea delle “timber cities” è diventata recentemente popolare: sostituire cemento e acciaio
con legno ingegnerizzato per ridurre le emissioni legate alla produzione dei materiali da
costruzione e stoccare carbonio degli edifici in legno, fino a realizzare una transizione in cui
entro il 2100 il 90% della nuova popolazione urbana viva in edifici realizzati con legno
strutturale ingegnerizzato (per esempio CLT e glulam).
Ma abbiamo abbastanza legno senza aumentare la pressione sulle foreste?

Gli autori partono da una fotografia quantitativa che spesso sorprende: oggi il carbonio immagazzinato nei prodotti in legno, a livello globale, equivale a un flusso di circa 0,33 miliardi di tonnellate di CO2-eq l’anno (di cui 0,04 nella solaEuropa), una grandezza paragonabile alle emissioni annuali di un Paese come la Spagna. Inoltre, per quantificare la quantità di legno necessaria a realizzare le timber cities, fissano un riferimento di domanda edilizia: assumono 30 m² di superficie utile pro capite (con un intervallo di sensibilità più ampio) e traducono la crescita della popolazione urbana in domanda annuale di legno strutturale ingegnerizzato.
La novità del lavoro sta anche nel suo metodo: un’analisi di flusso materiale Bayesiana, cioè una contabilità dei flussi di materia (legno) tra usi e settori, in cui i dati sono imperfetti e quindi si lavora con distribuzioni di probabilità, non con un solo valore “secco”. In altre parole: invece di fingere che le statistiche globali siano precise al millimetro, si incorpora esplicitamente l’incertezza mentre si ricostruisce il ciclo del legno e si simulano scenari. Secondo queste simulazioni, il volume di raccolta globale attuale del legno potrebbe essere sufficiente per sostenere città in legno, ma solo se cambia la destinazione d’uso del legno. La condizione cruciale è dirottare legno oggi usato come combustibile verso usi industriali, e contemporaneamente spingere al massimo circolarità e uso a cascata (riuso, riciclo, valorizzazione dei residui). La variabile che decide la fattibilità delle timber cities quindi non è soltanto “quanto tagliamo”, ma “quanto bruciamo” e “quanto riusiamo”.
Nello scenario in cui la transizione verso gli edifici in legno è accompagnata da forte circolarità e riduzione della combustione di legno vergine, gli autori stimano una riduzione delle emissioni cumulative entro il 2100 di circa 40,8 Gt CO2-eq rispetto a un business-as-usual. Dunque, aumentare la domanda di legno “buono” per prodotti durevoli può avere senso climatico solo se non si trascina dietro anche una domanda crescente di legno da bruciare, e solo se la filiera si organizza per tenere il materiale in circolo il più a lungo possibile. Le “città in legno” non sono solo un progetto architettonico: sono un problema di sistema, fatto di energia, industria, riuso dei rifiuti, logistica e norme.
2) The global deforestation footprint of agriculture and forestry (West et al., Nature Reviews Earth & Environment)
Il secondo studio sposta l’attenzione dall’uso del legno, e di molti altri prodotti a rischio di deforestazione, dal consumo finale alla geografia delle filiere. La parola chiave è deforestation footprinting: metodi che attribuiscono la perdita di foresta alla produzione di specifici beni di consumo, incrociando flussi commerciali internazionali, trasformazioni intermedie e re-export. È il tentativo di rispondere a una domanda che spesso resta senza risposta: chi è responsabile della deforestazione, il Paese che la ospita o quello che consuma i prodotti che la causano?
Per cominciare, gli autori ricordano che deforestazione e disturbi contribuiscono a emissioni globali di circa 8,1 ± 2,5 Gt CO2eq l’anno. E poi quantificano il driver dominante: l’86% della deforestazione globale tra 2001 e 2022 deve essere attribuita a colture e allevamento bovino. In secondo luogo, lo studio prova a fare chiarezza sulle definizioni e sulle differenze tra dataset relativi alla deforestazione. La revisione ricorda la definizione FAO di foresta (superficie >0,5 ha, alberi >5 m, copertura >10%), mentre prodotti di remote sensing come Global Forest Watch usano soglie diverse, per esempio copertura >30% a 30 m di risoluzione, e riportano la perdita di copertura arborea sia permanente che temporanea (tree cover loss), cioè dovuta sia a deforestazione che a disturbi o tagli, dopo i quali il bosco è in grado di rigenerarsi. Se non separiamo “perdita temporanea” da “conversione permanente”, rischiamo di attribuire alle filiere forestali un impatto sovrastimato, oppure, al contrario, di perdere pezzi di conversione reale di uso del suolo mascherata da gestione forestale.
Per capire e ridurre la deforestazione non basta guardare “dove cade l’ultimo albero”. Bisogna ricostruire il percorso che collega quel taglio a chi, alla fine, compra e consuma i prodotti che lo rendono conveniente, risalendo le filiere come si fa con i fiumi: tenendo conto di più punti di origine – le aziende agricole, gli allevamenti, i tagli forestali, e ricostruendo l’unirsi e il rimescolarsi dei flussi tramite raccolta, trader, trasformazione industriale, esportazione, importazione, re-export. In mezzo ci sono “salti” e deviazioni: un prodotto può essere lavorato in un Paese, trasformato in un altro, e venduto in un terzo con un’etichetta che non dice più nulla dell’origine. Esistono anche flussi sotterranei, passaggi commerciali costruiti apposta per rendere meno visibile la provenienza dei beni di consumo, per esempio tramite intermediari o miscelazione di partite, e punti ciechi, quando mancano dati o tracciabilità, e quindi non è possibile collegare in modo credibile il consumo finale alla perdita di foresta. Per questo, i metodi più solidi non si fermano al primo confine nazionale. Usano modelli chiamati MRIO (multi-regional input–output): grandi tabelle economiche che descrivono chi compra cosa da chi, in molti Paesi e settori, e permettono di “seguire” la domanda di un prodotto fino alle produzioni che la sostengono nei Paesi d’origine. Poi li combinano con dati fisici, per esempio tonnellate di soia, carne o legname, e con carte spazialmente esplicite di deforestazione, in modo da attribuire una quota della deforestazione non solo al luogo dove avviene, ma anche ai consumi che la trainano.
Infine, gli autori ricordano un limite importante: gran parte delle stime è buona nel ricostruire la deforestazione agricola, perché per colture e allevamenti esistono dati globali relativamente solidi. Ma per altri driver, come estrazione mineraria, infrastrutture, acquacoltura su mangrovie, i dati sono più frammentari e meno standardizzati. Se il dato di partenza è debole, anche il calcolo dell’impronta lo è, e il risultato pratico è che queste cause “minori” rischiano di apparire più piccole di quanto siano davvero, semplicemente perché non le vediamo bene nei numeri.
Dentro questo quadro, il messaggio per chi discute di “più legno per decarbonizzare” è inevitabile: ogni aumento di domanda va letto anche come potenziale spostamento di pressione su altre regioni e altre foreste, e va controllato con strumenti di tracciabilità e dovuta diligenza che parlino la lingua delle filiere, non solo dei confini amministrativi.
3) Carbon implications of wood harvesting and forest management (Sohngen et al., Nature)
È davvero possibile che tagliare alberi, a scala globale, “tolga” CO₂ dall’atmosfera invece di aggiungerla? Il terzo articolo di cui parliamo oggi è fatto da due “puntate” di un dibattito scientifico, accesosi proprio attorno a questa domanda. Dietro c’è una scelta tutt’altro che accademica: come misuriamo l’impronta climatica del legno quando entra nelle politiche energetiche, nei piani forestali, nelle strategie industriali.
Il punto di partenza è un articolo su Nature del 2023, firmato da Liging Peng, Timothy Searchinger e colleghi, che prova a quantificare il “costo climatico” dei prelievi legnosi mondiali tra 2010 e 2050. L’idea è semplice da spiegare, anche se impegnativa da modellare: ogni taglio viene confrontato con un controfattuale “senza taglio”, cioè con la quantità di carbonio che quella stessa foresta avrebbe continuato a stoccare se fosse stata lasciata crescere senza interventi. La differenza fra i due percorsi, anno dopo anno, è interpretata come carbonio “in più” in atmosfera attribuibile al prelievo, tenendo conto anche di dove finisce il carbonio del legno (prodotti, energia, decomposizione) e della ricrescita dopo il taglio.
La scelta metodologica più controversa in questo bilancio è stata applicare un “peso maggiore” alle emissioni più vicine nel tempo, usando un tasso di sconto (4%) sui flussi di emissioni e rimozioni che seguono a ogni anno di raccolta. In pratica, gli autori dell’articolo originale hanno scelto di tradurre il bilancio climatico decennale in “emissioni equivalenti nell’anno del taglio”, perché per gli obiettivi climatici fa differenza se la CO₂ viene emessa o sequestrata oggi oppure fra trent’anni. In questo quadro, il risultato centrale è forte: le emissioni associate ai prelievi globali sarebbero sottostimate di circa 3,5-4,2 Gt CO₂e/anno. E nonostante siano stati stimati anche i “benefici di sostituzione” (legno al posto di acciaio e cemento, o di combustibili fossili), questi benefici non cancellano automaticamente il costo biogenico, cioè la perdita di carbonio che la foresta avrebbe potuto continuare a tenere fuori dall’atmosfera.

Ebbene, lo studio è stato oggetto nel 2025 di una critica formale, sempre su Nature, di Sohngen e colleghi. Non si contesta che un taglio forestali rilasci carbonio, ma si fa notare come una foresta gestita sia in realtà una somma di soprassuoli di età, turni, incrementi, moduli selvicolturali, e usi del legno molto diversi tra loro. Se la domanda di legno cambia, cambieranno anche le decisioni dei proprietari e l’allocazione dei tagli nello spazio e nel tempo; e se in un posto si smette di tagliare, altrove si taglierà di più. Per questo, sostengono, uno scenario controfattuale “senza taglio” applicato ettaro per ettaro e poi sommato su milioni di ettari rischia di produrre una stima distorta a scala globale, perché trascura gli “aggiustamenti” del sistema e il cosiddetta leakage, cioè la delocalizzazione dei prelievi. Secondo i critici, l’approccio più corretto sarebbe misurare il flusso netto di carbonio attualizzato (crescita meno prelievi, più turnover dei prodotti) sull’insieme delle foreste gestite: se lo stock cresce, il sistema può avere effetto neutro o persino positivo, pur in presenza di tagli. Infine, sostengono, è corretto “scontare” il carbonio, ma bisognerebbe fare il modo che il tasso di interesse modifichi anche le scelte di gestione, cambiando i turni, gli investimenti e quindi le emissioni risultanti.
La controreplica dei primi autori (Searchinger, Berry, Peng) ribalta di nuovo la prospettiva. Difende il controfattuale “senza attività umana” come riferimento standard per attribuire le emissioni alle azioni umane. L’alternativa proposta dai critici, cioè adottare un controfattuale economico, rischia invece di confondere le emissioni prodotte da un’attività con le emissioni evitate rispetto a un’altra attività ipotetica, Il rischio, secondo Searchinger, è che così non staremmo più misurando “le emissioni del taglio”, ma confondendo le emissioni generate dal legno con quelle generate usando qualcos’altro in un mondo ipotetico. Sarebbe come dire: “guidare questa auto a benzina emette CO₂, ma se non la guidassi prenderei un taxi, quindi in confronto forse è meglio così”. Può anche essere vero in certi casi, ma non cambia il fatto che la benzina che brucia emette CO₂. Se si confondono queste due domande, “quanta CO₂ emetto facendo X” e “quanto X è meglio o peggio di Y”, si rischia di non attribuire più a nessuno le emissioni reali del legno, perché vengono assorbite nel gioco dei confronti tra scenari. Una ulteriore critica, piuttosto tecnica, attacca la credibilità di alcuni risultati di modelli economici globali del legno (in particolare il GTM citato da Sohngen et al.) quando arrivano a suggerire che più domanda di legno possa portare automaticamente a più foreste e quindi a un bilancio climatico negativo, un risultato che potrebbe invece provenire da parametri poco fondati o mal interpretati. Infine, sostengono gli autori del primo studio, molti modelli economici globali tendono a comportarsi come se gran parte delle foreste accessibili fosse gestita solo per massimizzare profitti da legname. Ma a scala mondiale una quota enorme di foreste è pubblica e ha obiettivi multipli; e persino dove la proprietà è privata, la redditività del legname spesso non è la motivazione dominante. Se un modello assume che gli alberi restino in piedi solo perché “prenotati” per soddisfare una domanda futura già prevista, allora la domanda aggiuntiva non può attingere agli stock esistenti e finisce per essere soddisfatta con espansione di area o intensificazione, riducendo artificialmente il costo di carbonio del legno.
In definitiva, calcolare il “costo di carbonio” dei tagli non è semplice come applicare un’etichetta standard a tutte le circostanze, ma il risultato di una scelta esplicita su che cosa stiamo confrontando, in quale orizzonte temporale, e con quali assunzioni sulla domanda e sulla risposta delle foreste e dei mercati. Se la domanda è: “tagliare oggi, rispetto a lasciare quel bosco crescere indisturbato, aumenta la CO₂ in atmosfera nei prossimi decenni?”, allora la risposta è spesso sì: il taglio crea un debito iniziale, perché rimuove biomassa e interrompe (almeno temporaneamente) l’accumulo di carbonio. Quel debito può essere ripagato solo se la ricrescita avviene davvero e abbastanza in fretta, e se una quota rilevante del legno finisce in prodotti durevoli o sostituisce materiali o energia più emissivi. Il rientro può richiedere tempi lunghi e può non avvenire se aumentano mortalità, incendi, degradazione o conversione d’uso del suolo. Se la domanda è: “in un sistema economico reale, con domanda di legno che si sposta e con gestione e piantagioni che reagiscono, qual è l’impatto netto globale?”, allora il “debito” può risultare più piccolo di quello stimato con un confronto ettaro-per-ettaro, e in alcuni casi può diventare vicino allo zero o positivo, ma solo con assunzioni forti su mercati, effetti di sostituzione e dinamiche di uso del suolo, che vanno dichiarate prima di fare i conti.

Al prossimo episodio!
Info Autori
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)
Università degli Studi di Milano