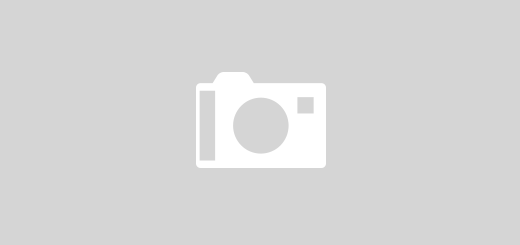Selvicoltura “più vicina alla natura” e gestione dei “boschi di protezione diretta”, sinergie e divergenze in ambiente mediterraneo

Il recente Testo Unico sulle Foreste e Filiere Forestali ha messo in evidenza il ruolo rilevante dei boschi di protezione diretta. In ambiente alpino il tema ha già trovato importanti sviluppi ereditando da esperienze svizzere e progetti transfrontalieri. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte hanno pubblicato già 20 anni fa linee guida per la gestione di boschi di protezione diretta.
Più recentemente, l’Unione Europea ha promosso una selvicoltura “più vicina alla natura”, mettendo il tema della biodiversità al centro della gestione forestale attiva.
Ma come si relazionano, in ambiente mediterraneo, i due paradigmi?
Se da un lato entrambi gli approcci promuovono copertura continua, diversità strutturale e adattabilità, dall’altro emergono differenze significative: la selvicoltura di protezione richiede interventi tesi a indirizzare o mantenere caratteri chiave della struttura del bosco all’interno di un range di valori ritenuti efficaci, mentre l’approccio “vicino alla natura” privilegia minimi disturbi e la regolazione naturale dei processi ecologici.

Macchia in protezione diretta (foto courtesy: Alessandra Manca)
Quanto è compatibile dunque, in questi ambienti, la selvicoltura “più vicina alla natura”, orientata alla biodiversità e alla resilienza, con la gestione funzionale delle foreste di protezione, fondamentale per mitigare frane, erosione e altri rischi naturali?
Uno studio appena pubblicato dall’Università di Sassari propone una risposta a questa domanda. I territori mediterranei, “contaminati” da millenaria influenza umana, sono caratterizzati da maggiore complessità sotto il profilo ecologico e gestionale, elevata biodiversità, eterogeneità strutturale, notevole vulnerabilità agli incendi e lunghi periodi di siccità. In questi contesti, traslare le linee guida alpine senza adottare opportuni adattamenti può risultare non solo difficile, ma addirittura controproducente. Al tempo stesso, alcuni principi della selvicoltura “vicina alla natura” possono rivelarsi persino più efficaci nel garantire la protezione in questi ambienti che nelle Alpi.

Cedui in protezione diretta (foto courtesy: Alessandra Manca)
Lo studio suggerisce di sviluppare un modello ibrido e flessibile, con linee guida modulate sulle specificità ecologiche e geomorfologiche dell’ambiente mediterraneo, capaci di valorizzare boschi di neo-formazione, nati dall’abbandono, la macchia e i cedui, elementi in genere sottovalutati come parte integrante delle foreste di protezione, riconoscendo il loro ruolo nella stabilizzazione dei suoli grazie a ricacci rapidi e apparati radicali densi. L’obiettivo è garantire una continuità della vegetazione, la capacità rigenerativa e la protezione dei suoli, mettendo al centro adattamento, governance partecipata e integrazione delle tradizioni locali, elementi chiave per la sostenibilità nella cura del territorio e per rafforzare sia la funzione protettiva sia il sostegno sociale delle scelte gestionali.
Solo costruendo una gestione su misura—basata sull’integrazione tra funzione protettiva, biodiversità e sostenibilità sociale—le foreste mediterranee potranno continuare a costituire paesaggio e biodiversità e sostenere e proteggere le comunità che vi abitano.