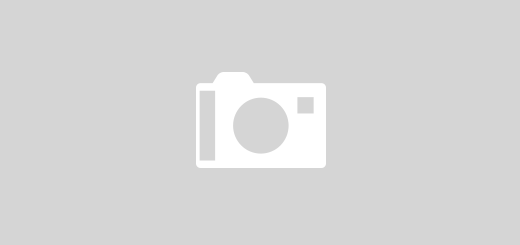La penisola italiana conserva ancor più diversità genetica di quanto già atteso per il suo importante ruolo di rifugio glaciale?

Per la rubrica SISEF “Pillole di Scienze Forestali” pubblichiamo il contributo di Andrea Piotti e Camilla Avanzi del CNR-IBBR.
La penisola italiana conserva ancor più diversità genetica di quanto già atteso per il suo importante ruolo di rifugio glaciale? Questa l’affascinante ipotesi che sembrano suggerirci due recenti lavori su abete rosso e farnia pubblicati sulle riviste Review of Palaeobotany and Palynology e Diversity and Distributions.
Per quanto riguarda l’abete rosso, un gruppo di ricercatori dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze (CNR-IBBR) e dell’Università La Sapienza ha
utilizzato dati genetici e paleobotanici per mostrare come i nuclei residuali presenti ai margini
dell’areale italiano della specie (Riserva di Campolino – Valle del Sestaione; Lago Verde – Val
Cedra; Valdieri – Alpi Marittime) si siano tutti originati da differenti rifugi glaciali e, di conseguenza,
abbiano caratteristiche genetiche peculiari che li rendono molto diversi tra loro e dal resto delle
popolazioni alpine.
Se quest’ipotesi venisse confermata, in particolare da un ampio dataset genomico appena
assemblato nell’ambito del progetto europeo FORGENIUS, e venissero evidenziate particolari
specificità delle popolazioni marginali per quanto riguarda la quota di diversità genetica con
rilevanza adattativa (quella che riguarda geni coinvolti in risposte ad agenti stressogeni), ci
troveremmo di fronte a un ‘caso’ conservazionistico davvero complicato – e decisamente urgente
da affrontare. Ma i dati genetici, oltre a evidenziare la complessità della situazione, con tante
piccole popolazioni peculiari che rischiano di scomparire, potranno ovviamente anche aiutarci a
trovare soluzioni ottimali per la conservazione di queste preziose risorse genetiche forestali!

Nel lavoro pubblicato su Diversity and Distributions, invece, i genetisti forestali CNR-IBBR hanno
indagato la diversità genetica e la passata storia demografica della farnia nel suo areale di
distribuzione italiano, e discusso anche qui la rilevanza conservazionistica dei risultati, con
particolare enfasi sull’attuale distribuzione dei boschi da seme e delle Genetic Conservation Units
della specie.
A conferma di quanto trovato nelle poche specie forestali oggetto di approfonditi studi genetici in
Italia, come l’abete bianco, e in linea con i risultati sull’ abete rosso appena descritti, la
distribuzione della diversità genetica della farnia in Italia mostra una notevole complessità.
Esistono tre principali gruppi genetici differenziati: un gruppo genetico tipico del sud Italia, ormai
relegato quasi unicamente nel nucleo del Bosco Pantano di Policoro; un complesso gruppo
genetico presente in Italia centrale e caratterizzato al suo interno da ulteriori sotto-gruppi; e, infine,
un gruppo estremamente omogeneo dal punto di vista genetico che caratterizza l’intero bacino
padano-veneto. L’Italia centrale, oltre a essere l’area con la maggiore complessità nella struttura
genetica, ospita popolazioni con elevata diversità genetica.

La peculiare distribuzione della diversità genetica riscontrata nelle specie studiate – che riflette
l’esistenza di un complesso mosaico di aree rifugio e uno snodo cruciale di rotte di migrazione
durante i cicli glaciali del Quaternario nella nostra penisola – esorta a intraprendere una revisione
delle aree di tutela e, soprattutto, delle strategie di conservazione ex situ del nostro ricchissimo
patrimonio forestale. Questi aspetti sono stati ulteriormente discussi in un articolo dedicato,
pubblicato in parallelo sulla rivista Biological Conservation, in cui, per la prima volta in Europa,
sono state applicate tecniche di Spatial Conservation Planning (SCP) a dati genetici su specie
forestali. I risultati di tali approcci permettono di ottimizzare le risorse necessarie per mantenere
una rete di aree di conservazione in base alla massimizzazione di un obbiettivo, ad esempio il
mantenimento un livello di diversità genetica che scongiuri il rischio di maladattamento alle future
condizioni climatiche.
Sappiamo ancora poco della diversità genetica delle foreste italiane, ed ogni approfondimento
genera più sorprese che conferme di ipotesi basate su dati scarsi e ormai datati. Il prossimo anno
saranno finalmente disponibili numerosi dataset genomici basati su un campionamento denso e
capillare di parecchie specie forestali (abete bianco, faggio, pino d’Aleppo, pino domestico, pino marittimo, sughera, farnia, frassino maggiore, farnetto), così come le prime esplorazioni genetiche
di specie meno studiate (come bagolaro, carpino bianco, cerro, acero campestre, tiglio).
Vedremo se la straordinaria complessità nella struttura genetica emersa per abete rosso e farnia verrà
confermata da questi nuovi dati.
Leggi altri contenuti della Rubrica Pillole di Scienze Forestali
Si ringraziano Andrea Piotti e Camilla Avanzi per il contributo