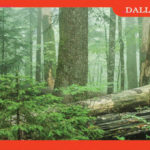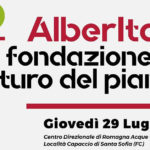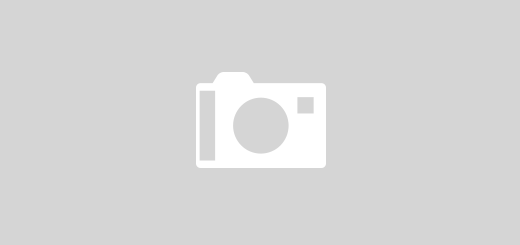Giro Forestale d’Italia – continua la settimana 3

La terza settimana del Giro Forestale d’Italia è iniziata così
Tappa 18 – Il Bosco di Vanzago: Un’oasi tra le fabbriche
In mezzo al paesaggio frammentato dell’Alto Milanese, tra capannoni industriali, strade trafficate e centri commerciali, esiste un luogo dove il tempo ha preso una direzione diversa. È il Bosco WWF di Vanzago: 200 ettari verdi eredi dei grandi boschi di caccia dei Visconti e degli Sforza, sopravvissuti come un piccolo miracolo ecologico, che oggi non sono più solo un rifugio per animali e piante, ma anche una scuola di ripristino, conservazione e gestione forestale.
Vanzago non è nato da un grande progetto di riforestazione post-trauma, come nel caso di Valtrigona. Non è nemmeno un relitto naturale completamente abbandonato alla sua evoluzione spontanea. È il risultato di un lungo e paziente lavoro di tutela attiva, dove ogni intervento – o ogni non-intervento – è stato deciso alla luce della scienza ecologica, con uno sguardo rivolto al futuro. E proprio in questo equilibrio tra passato e possibilità, Vanzago è diventato uno dei più importanti laboratori forestali della pianura padana.

Oasi WWF, Bosco di Vanzago, foto di archivio
Il cuore nobile del Bosco di Vanzago
Il Bosco di Vanzago conserva un frammento raro e prezioso della vegetazione forestale originaria della Pianura Padana: il querco-carpineto. Un tipo di bosco di latifoglie miste mesofilo, che si sviluppa naturalmente in condizioni di pianura umida ma ben drenata, e che un tempo ricopriva vaste superfici della Val Padana. Oggi è considerato un habitat protetto (codice 9160) per la sua rarità e importanza ecologica, e fa da punto riferimento per molti progetti di ricostituzione di boschi di pianura ormai scomparsi. Nel Bosco di Vanzago questo habitat si manifesta in tutta la sua diversità, con strati arborei dominati da querce come la farnia (Quercus robur) e la rovere (Q. petraea), accompagnate da carpini bianchi (Carpinus betulus), aceri campestri, olmi e tigli. Alcuni individui secolari raggiungono i 25 metri d’altezza. Il sottobosco, dove sopravvive una flora preziosa e in parte minacciata (mughetti, pervinche, anemoni, sigillo di Salomone), è stato a lungo compromesso dalla diffusione di specie aliene, ma oggi viene pazientemente ripristinato.
Lo Stellario-Carpinetum è infatti una comunità ecologica stratificata e stabile, che richiede continuità nella copertura arborea e nei cicli naturali di disturbo. La gestione del bosco da parte del WWF mira a ripristinare questa struttura, riducendo la pressione delle specie esotiche (robinia, ciliegio tardivo, ailanto e fitolacca) che hanno determinato la destrutturazione del bosco (strati arbustivi ed erbacei quasi completamente assenti) e un notevole abbassamento della biodiversità floristica, e favorendo la rinnovazione naturale delle specie autoctone, in modo che questo ecosistema antico possa affrontare le sfide del futuro e continuare a offrire rifugio a una biodiversità unica.
Alieni a confronto
Quando parliamo di specie invasive nelle foreste europee, tendiamo a metterle tutte nello stesso sacco. Ma non tutte si comportano allo stesso modo, e soprattutto, non tutte fanno danni con la stessa intensità. Uno studio pubblicato in Polonia nel 2025 getta nuova luce su due protagoniste silenziose dell’invasione forestale: la robinia (Robinia pseudoacacia) e il ciliegio tardivo (Prunus serotina).

Bosco di Vanzago – Franco Sala
Lo studio mette a fuoco il concetto chiave di invasional meltdown: accade quando la presenza di una specie aliena favorisce indirettamente l’insediamento di altre specie non native, creando una sorta di effetto domino. I ricercatori hanno osservato che maggiore è la biomassa di robinia, più aumentano anche le coperture di altre specie esotiche. È come se la robinia “preparasse il terreno”, alterando condizioni microclimatiche, chimica del suolo e dinamiche del sottobosco in modo tale da rendere l’habitat più accogliente per altri invasori.
Il ciliegio tardivo, al contrario, non crea lo stesso effetto a catena, ma agisce in modo più paziente. Si insinua lentamente negli strati bassi del bosco, vegetando all’ombra delle specie native e disperdendo semi dormienti nella lettiera. Appena una finestra di luce si apre — un albero cade, un taglio forestale viene eseguito — il ciliegio tardivo prende il sopravvento, sfruttando il momento giusto per accelerare la propria crescita e battere sul tempo la rinnovazione delle specie autoctone. In pochi anni colonizza tutto: cresce in altezza, emette nuovi polloni, fa ombra alle giovani piante native e ne impedisce la crescita. Ma non è tutto. Le sue foglie contengono acido cianidrico, poco gradito alla microfauna del suolo e agli erbivori. Il risultato? Un impoverimento drastico dell’ecosistema: dove prima c’erano 40 o 50 specie vegetali, ora ce ne sono 5 o 6. Un bosco che diventa silenzioso, uniforme, meno vivo.
Il secondo concetto importante è che l’impatto di queste invasioni dipende fortemente dalla cosiddetta biotic resistance o acceptance, cioè la capacità dell’ecosistema forestale ospite di resistere o accettare l’invasione. Lo studio dimostra che le invasioni sono più gravi in foreste giovani (meno di 80 anni), con minore copertura arborea (più luce al suolo), dove il suolo è più fertile o disturbato, e dove la diversità delle specie autoctone è bassa, e quindi non si esercita una competizione efficace. In parole semplici: più il bosco è “debole” o squilibrato, più le specie aliene riescono a penetrare e diffondersi.
Per limitare gli “alieni” non bastano i continui interventi di taglio e rimozione, il segreto è invece favorire occorre lo sviluppo di un bosco denso e stratificato, dove la luce scarseggia e le specie invasive fanno più fatica a prosperare. Per questo, a Vanzago si lavora su due fronti: si combattono gli invasori, ma si rafforzano anche gli “alleati naturali” — le querce, i carpini, gli aceri — che con la loro ombra e la loro stabilità possono riportare equilibrio. È una lotta lenta, come quella di certi scalatori che arrancano in salita senza clamore, ma con costanza. E proprio come in quelle salite, non sempre conta la velocità: conta la resistenza, la visione a lungo termine, la scelta giusta al momento giusto.

Bosco di Vanzago – Franco Sala
Un bosco da seme: dove nasce il futuro della farnia
C’è un altro motivo per cui il Bosco di Vanzago è un luogo speciale, e riguarda il futuro di uno degli alberi simbolo delle foreste planiziali europee: la farnia. Il Bosco di Vanzago è infatti un bosco da seme iscritto nei registri per la conservazione genetica della farnia. Le querce che vi crescono producono ogni anno ghiande certificate, raccolte con cura e utilizzate nei vivai forestali per avviare nuovi impianti o ripristinare boschi degradati.
Essere un bosco da seme non è un’etichetta formale: è una responsabilità ecologica. Significa mantenere integre le caratteristiche genetiche del popolamento, proteggere gli alberi madre, evitare ibridazioni con varietà alloctone o ornamentali. È come avere tra le mani una banca vivente del DNA della farnia, costruita dal tempo e dalla selezione naturale.
In un’Italia dove i boschi planiziali originari sono ridotti a brandelli — meno dell’1% della superficie che un tempo occupavano — custodire questi alberi non è solo una scelta di conservazione, è un atto di lungimiranza. Perché il cambiamento climatico impone nuove sfide anche alle foreste, e avremo sempre più bisogno di piantare alberi nati da semi giusti, nel posto giusto. E molti di quei semi, oggi, nascono proprio qui.
CO₂: facciamo bene i conti
Nell’epoca dell’emergenza climatica, l’idea di piantare alberi è diventata quasi un riflesso condizionato, una promessa semplice e rassicurante. Ma quanto carbonio può davvero sottrarre all’atmosfera un nuovo bosco di pianura che prenda a modello quello di Vanzago? La scienza ha iniziato a rispondere con numeri sempre più precisi, ed è proprio da qui che nasce il valore aggiunto di un’oasi come questa.
Secondo uno studio dell’Università di Bologna, in condizioni ambientali favorevoli e con cure colturali adeguate, una nuova piantagione di latifoglie decidue in pianura può assorbire in media circa 3,5 tonnellate di carbonio per ettaro all’anno (equivalenti a circa 13 tonnellate di CO₂), nei primi decenni di vita. Si tratta di valori che, seppure inferiori a quelli dei pioppeti intensivi (che possono arrivare anche a 12,9 t C ha⁻¹ anno⁻¹), sono pienamente compatibili con obiettivi di conservazione, biodiversità e durata del sequestro nel tempo.
Nel caso di Vanzago, il potenziale di assorbimento si rafforza grazie alla presenza di una copertura forestale matura, ben strutturata e ricca di specie autoctone. Inoltre, i boschi come questo garantiscono una fissazione più stabile e duratura nel tempo, grazie alla longevità delle specie presenti, alla presenza di legno morto in fase di decomposizione e alla capacità del suolo di fungere da serbatoio.
Per dare un’idea della portata complessiva, piantando 10 000 ettari di nuovi boschi analoghi, si potrebbero sottrarre all’atmosfera circa 1,7 milioni di tonnellate di carbonio in 50 anni, ovvero 6,4 milioni di tonnellate di CO₂. Un contributo strategico in ambito periurbano o agricolo e in contesti come quello dell’Alto Milanese, dove natura, città e clima si intrecciano. Dall’altra parte, occorre ricordare che le emissioni nazionali di gas climalteranti si sono attestate nel 2023 a 384,7 milioni di tonnellate di CO₂. Tenere a mente queste cifre può essere molto utile per non sopravvalutare il ruolo delle foreste nel mitigare le cause della crisi clmatica e diffidare dalle stime mirabolanti di assorbimento in cui può capitare di imbattersi quando viene riferito un nuovo progetto di impianto.
Mani leggere e pensieri lunghi
Gestire un bosco come quello di Vanzago non significa soltanto piantare alberi o tagliare quelli indesiderati. È un’arte paziente, fatta di osservazione, scelte calibrate e molto ascolto del bosco, come ci racconta il Piano di Gestione della riserva. Qui, tra i sentieri ombrosi e le radure silenziose, la selvicoltura non è mai un gesto meccanico, ma una forma di cura. Tutto parte da un’idea semplice: aiutare il bosco a diventare se stesso, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Per farlo, gli interventi sono pensati con mani leggere e pensieri lunghi. Si lavora per migliorare il soprassuolo esistente, accrescendo la biodiversità e ricostruendo, un passo alla volta, l’antica fisionomia della foresta planiziale: quella dei grandi querco-carpineti, dove la luce danza solo in punta di piedi e il sottobosco è vivo, fitto, protettivo.
Negli ultimi vent’anni, qui sono stati convertiti vecchi cedui di robinia in boschi ad alto fusto, sono stati tagliati gli alberi maturi di ailanto e ciliegio tardivo, sono stati messi a dimora carpini, querce, frassini, aceri. Ma non basta piantare: serve accompagnare, proteggere i giovani alberi dalla competizione, contenere l’avanzata delle specie esotiche, mantenere il sottobosco ombroso e ricco.

WWF Italia, Bosco di Vanzago
Anche il legno morto ha trovato un nuovo posto nella narrazione del bosco. Non è più un residuo da rimuovere, ma una risorsa ecologica, rifugio per insetti saproxilici, serbatoio di carbonio, pezzo di un mosaico che aumenta la naturalità dell’intero ecosistema. Solo nei luoghi più frequentati dai visitatori o dove c’è rischio per la sicurezza si interviene con cautela per rimuovere i fusti pericolanti.
Non si fa nulla per forza. Ogni taglio è un gesto pensato, mirato, limitato: piccoli diradamenti dal basso, rimozione degli individui morti o deperienti, mai su larga scala. Si agisce poco e bene, sapendo che la vera forza di una foresta è nella sua continuità, nella stratificazione delle età, nel tempo lento della successione naturale. Così Vanzago cresce, non come un monumento, ma come una comunità vivente. Un laboratorio a cielo aperto dove si sperimenta, si monitora, si sbaglia anche – ma sempre con l’idea che gestire il bosco è ascoltarlo, non dominarlo.
Info Autori
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)
Università degli Studi di Milano