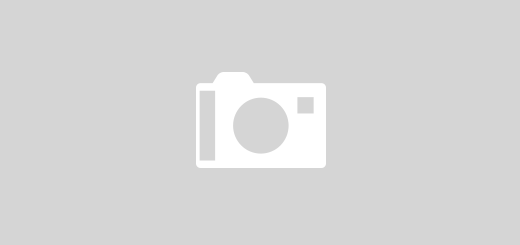Foreste culturali

Per la rubrica SISEF “Pillole di Scienze Forestali” pubblichiamo il contributo di Mauro Agnoletti, Università degli Studi di Firenze.
La rivista Biodiversity and Conservation ha pubblicato poche settimane fa uno special issue dedicato alle foreste culturali, il quale raccoglie articoli provenienti da varie parti del mondo.
Si tratta di foreste modellate per lungo tempo dall’opera dell’uomo, che ne ha influenzato densità, composizione specifica, struttura, ma anche forma ed estensione. Le pratiche tradizionali applicate da millenni in tutto il mondo hanno permesso alle comunità rurali di ottenere molteplici prodotti e servizi e di preservare la diversità forestale. Hanno inoltre contribuito alla creazione e conservazione di una vasta gamma di tipologie forestali e di habitat diversificati che ospitano numerose specie di animali, funghi, piante e microrganismi.
Fra i casi più interessanti i boschi di Argan (Argania spinosa (L.) Skeels) nel Marocco sud-occidentale, boschi multifunzionali legati alla produzione di un frutto simile all’oliva che produce un olio utilizzato sia per scopi cosmetici che alimentari. L’albero è in grado di spingere le sue radici fino a decine di metri in profondità resistendo così a prolungati periodi di siccità. Le capre si arrampicano sui suoi rami per mangiare il frutto che, tradizionalmente, veniva raccolto e lavorato dopo la digestione, mentre oggi è raccolto prima del pascolamento.

Per l’Italia, oltre ad uno studio generale sulle caratteristiche culturali dei boschi italiani, è presente una indagine sul sito delle “Colline del Prosecco, Conegliano e Valdobbiadene”, iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero dell’Agricoltura e poi nella World Heritage List dell’UNESCO.

La particolare struttura spaziale derivante dalle molteplici interazioni fra vigneto e bosco costituisce uno dei principali caratteri di unicità di questo paesaggio. I boschi costituiscono più del 50% dell’area, nonostante pendenze che raggiungono anche il 70% sono stati estesamente governati a ceduo e sono gestiti con un piano di gestione ad indirizzo paesaggistico-culturale.
In varie parti del mondo, l’abbandono delle pratiche forestali tradizionali combinato con la riduzione degli spazi coltivati e di quelli destinati al pascolo, come accaduto in Europa, ha portato alla omogeneizzazione e semplificazione del paesaggio forestale. Questo processo è stato sostenuto anche da politiche che hanno favorito la limitazione delle pratiche tradizionali, portando alla diminuzione e/o alla perdita degli habitat legati a questi modelli gestionali e alla riduzione della biodiversità a scala di
paesaggio.
Già nel 1980 nel Regno Unito si era sviluppata una iniziativa riguardante le cosiddette “Ancient Forests”, rivolta ad inventariare foreste sia di origine storica sia di origine naturale. Nel 2003 la Conferenza Interministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE) aveva identificato i valori socioculturali come il terzo pilastro della Gestione Forestale Sostenibile, mentre la IUFRO propose linee guida per la loro implementazione politica.
L’Italia, unico paese del continente europeo, ha promosso una legge, in corso di attuazione, volta ad istituire un elenco nazionale di boschi di valore storico-culturale dotati di specifici piani di gestione, introducendo così nuovi valori e nuovi obiettivi nelle strategie di conservazione.
Leggi lo special issue su Biodiversity and Conservation per approfondire
Leggi altri contenuti della Rubrica Pillole di Scienze Forestali
Si ringrazia Mauro Agnoletti per il contributo