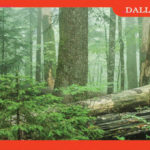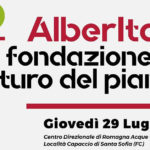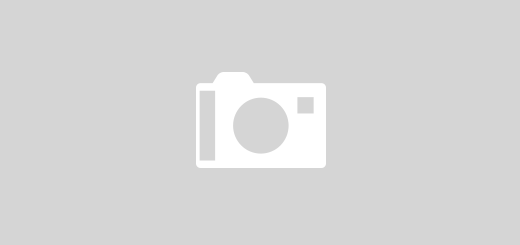Giro Forestale d’Italia

I boschi attraversati dalla PRIMA SETTIMANA del Giro D’Italia
La prima settimana del Giro d’Italia 2025 porterà i corridori dall’Albania alle porte della Campania, quindi attraverserà l’Italia centrale tra colline, coste e altipiani.
Ma il Giro è molto più di una gara ciclistica: è una macchina narrativa, un viaggio collettivo che ogni anno ci ricorda quanto sia variegato e straordinario il nostro territorio. Ogni curva e ogni salita offriranno come sempre uno scorcio su paesi, culture e paesaggi che compongono la nostra identità. E se i borghi, le città d’arte e le tradizioni enogastronomiche sono da tempo protagonisti del racconto televisivo e mediatico del Giro, meno conosciuti — ma altrettanto fondamentali — sono i boschi italiani. Foreste planiziali, ripariali, mediterranee e montane costeggiano quasi ogni tappa del Giro. Ma non sono solo sfondo: sono sistemi viventi complessi, che forniscono acqua, ombra, biodiversità, aria pulita e resilienza climatica. Eppure, troppo spesso rimangono invisibili. Per questo, noi della SISEF, in collaborazione con WWF Italia, accompagneremo le tre settimane di corsa con tre articoli divulgativi dedicati alle foreste che il Giro sfiorerà, per raccontarne il valore scientifico, ecologico e gestionale.
In questa prima settimana ci fermiamo in tre luoghi-simbolo:
- il Bosco Pantano di Policoro,
- il Cratere degli Astroni,
- le Gole del Sagittario.
Tre oasi WWF, tre storie di boschi unici, minacciati ma vivi, da conoscere e proteggere.
Tappa 5: Ceglie Messapica – Matera
Bosco Pantano di Policoro: l’ultima foresta incantata
Quando la carovana del Giro raggiungerà Metaponto, piegherà verso l’interno risalendo la valle del Bradano per dirigersi a Matera. Ma se invece si proseguisse sulla litoranea ionica per circa 30 km, ci si troverebbe immersi in un altro tempo, in un altro paesaggio. Qui sorge il Bosco Pantano di Policoro, frammento prezioso e residuale di ciò che fu una delle più estese e importanti foreste planiziali dell’Italia meridionale.
Un tempo il bosco si estendeva ininterrotto dalla foce del fiume Sinni a quella dell’Agri. Era considerato sacro dai Greci, rifugio di caccia per i Borboni, attraversato solo da una via ombrosa e temuta: il Tratturo del Re. Nel 1931, ne erano stati censiti 1600 ettari. Oggi ne restano circa 680, dei quali appena 21 ettari sono protetti come Oasi WWF Policoro Herakleia, all’interno della Riserva Naturale Orientata istituita nel 1999.
Quel che resta, però, è un tesoro. Il bosco, immerso tra ambienti palustri, canneti, lagune, dune e macchia mediterranea, ospita oltre 2.000 specie, tra cui 170 uccelli migratori, coleotteri rari, anfibi, rettili, mammiferi, e tre specie di tartarughe (di terra, d’acqua dolce e marina). È tornata la lontra, predatore elusivo e simbolo della salute fluviale. E il centro recupero fauna dell’Oasi WWF è oggi uno dei più attivi nel Mezzogiorno, specializzato nella cura delle tartarughe marine ferite.

Oasi WWF Policoro, Matera
La foresta relitta e il genoma della farnia
Ma la parte più preziosa della riserva resta il bosco planiziale mesofilo, testimonianza vivente di un ecosistema ormai quasi scomparso. Si tratta di una foresta igrofila, che si sviluppa su suoli profondi, umidi, antichi, modellati da secoli di esondazioni del Sinni. La composizione è ricca: frassino, ontano nero, pioppo bianco, acero campestre, alloro, cerro, melo selvatico, biancospino, sanguinella, alaterno. Ma su tutte svetta un albero diventato simbolo di resilienza: la farnia.
Una popolazione relitta, fragile ma unica. Grazie agli studi genetici condotti dall’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR, le farnie del Bosco Pantano sono state inserite nella mappa europea EUFGIS, il network che raccoglie le Unità di Conservazione Genetica Forestale di maggiore interesse. Qui sopravvive una delle poche popolazioni autoctone di farnia ancora presenti sul margine meridionale della sua distribuzione, con tratti genetici potenzialmente cruciali per l’adattamento ai cambiamenti climatici. I circa 60 individui censiti rappresentano un patrimonio evolutivo che potrebbe contribuire, un giorno, alla ricolonizzazione di aree più settentrionali da parte della specie, man mano che il clima si riscalda. Questo è il cuore del progetto “L’Ultima Foresta Incantata”, portato avanti dal WWF insieme a nove enti tra cui l’Università della Basilicata: uno sforzo congiunto per monitorare, studiare e tutelare la biodiversità genetica del bosco, anche attraverso raccolte di semi certificati, interventi di reintroduzione e piani di adattamento.
Siccità e resilienza: cosa ci dicono i dati
Un recente studio coordinato dall’Università della Basilicata ha posto sotto la lente di ingrandimento proprio il Bosco Pantano di Policoro, confrontandolo con una foresta simile nel nord Italia. I ricercatori hanno analizzato la crescita annuale di quattro specie arboree tipiche delle foreste ripariali – farnia, frassino, ontano e olmo – utilizzando tecniche dendrocronologiche avanzate, indicatori climatici come l’indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), e un modello di crescita non lineare (VS-Lite) in grado di stimare gli effetti della temperatura e dell’umidità del suolo sulla formazione degli anelli di accrescimento.
I risultati sono chiari: il frassino è la specie più vulnerabile alla siccità, con forti cali di crescita durante gli anni più secchi, come il 1992. Anche la farnia mostra segnali di sofferenza, soprattutto nei periodi estivi caldi e secchi, mentre l’ontano nero risulta essere più resistente. Il modello ha confermato che la bassa umidità del suolo in primavera e in estate limita fortemente la crescita di frassino e farnia. E se in passato la falda superficiale proteggeva questi alberi dal deficit idrico, oggi il deflusso regolato del fiume Sinni, a causa di una diga costruita negli anni ’70, ha alterato il regime idrologico, rendendo il bosco più dipendente dalle precipitazioni.
Lo studio suggerisce che questi segnali possono essere utilizzati come indicatori precoci di declino forestale, utili per orientare gli interventi di restauro, come il miglioramento della connettività idrica, la promozione di specie resistenti e il monitoraggio della rinnovazione. In sostanza, la scienza ci conferma che il Bosco Pantano, oltre a essere un relitto prezioso, è un ecosistema sentinella: ci mostra in anticipo cosa potrebbe accadere in molte altre foreste mediterranee se non agiamo per tempo.

Oasi WWF Policoro, Matera
Un equilibrio fragile: pressioni e risposte
A questi fattori ecologici si sommano pressioni antropiche: disboscamento storico, bracconaggio, prelievo di legna, abbandono di rifiuti, disturbi alla fauna. Il Programma di gestione della riserva elenca tra i principali impatti:
- conservazione e promozione della rinnovazione naturale, con attenzione particolare alla farnia e alle specie mesofile;
- gestione del legno morto, fondamentale per la biodiversità (coleotteri saproxilici, funghi, uccelli cavicoli);
- recupero e manutenzione della struttura del bosco per aumentare eterogeneità, stabilità e resilienza;
- monitoraggio dello stress idrico e dei processi di mortalità, per anticipare i danni e guidare gli interventi;
- educazione ambientale e partecipazione, per rafforzare il legame tra comunità locali e patrimonio forestale.
Oggi, il Bosco Pantano di Policoro è un laboratorio di resistenza ecologica. Non è solo un rifugio per la fauna, un serbatoio di geni o un ricordo della natura che fu. È un nodo strategico per il futuro della biodiversità forestale del Mediterraneo. Un patrimonio che ha bisogno di cura, studio, ma anche di storie come questa, capaci di farlo conoscere a chi, al Giro o nella vita, corre veloce — e magari, per un attimo, decide di rallentare.
Tappa 6: Potenza – Napoli
Cratere degli Astroni: dentro il vulcano, una foresta da difendere
La tappa che dal cuore della Basilicata scivola giù fino al Golfo di Napoli è una delle più attese: salite brevi ma ripide, un arrivo tecnico, e il Vesuvio che veglia sullo spettacolo. Ma basta deviare all’uscita 11 “Agnano” della tangenziale di Napoli per cambiare scena, radicalmente. In pochi chilometri si passa dal frastuono della metropoli al silenzio verde di un cratere vulcanico spento. È il Cratere degli Astroni, Oasi WWF e Riserva Naturale dello Stato, una delle ultime aree forestali integre della provincia di Napoli.
Il cratere è uno dei più grandi e meglio conservati tra i trenta dei Campi Flegrei: formatosi tra 4100 e 3800 anni fa, è il risultato di sette eruzioni di tipo prevalentemente freato-magmatico. Ha un diametro massimo di quasi 2 km, un perimetro di 6,5 km e racchiude al suo interno un ecosistema straordinario, plasmato da fuoco e acqua.
Tra rilievi come il Colle dell’Imperatrice, la Rotondella e i Pagliaroni, si aprono zone pianeggianti dove tre specchi d’acqua — il Lago Grande, il Cofaniello Piccolo e il Cofaniello Grande — alimentano una vegetazione palustre ricca di tife, giunchi, canneti e saliconi. Qui nidificano folaghe, germani, aironi cenerini, tarabusini, mentre lungo i sentieri si possono osservare moscardini, ghiri, ricci, mustioli etruschi e decine di specie di farfalle. In tutto, si contano oltre 130 specie di uccelli: un patrimonio che si incontra a ogni passo, basta camminare piano.
La sua straordinarietà è resa possibile da un fenomeno climatico particolare: l’inversione termica. Sul fondo del cratere, l’umidità ristagna e le temperature si mantengono più basse rispetto ai bordi esposti. Qui, a pochi metri sul livello del mare, crescono farnia, castagno, rovere, carpini e olmo campestre — alberi che normalmente vivono centinaia di metri più in alto. Sulle pendici e sull’orlo assolato, invece, dominano leccio, lentisco, mirto, erica, corbezzolo, fillirea e altre specie mediterranee. È come se un piccolo Appennino e una macchia costiera si fossero dati appuntamento nello stesso luogo, protetti da un anello di tufo.

Oasi WWF Astroni, Napoli
Fuoco e rinascita
Tanto equilibrio, però, è fragile. Tra il 14 e il 23 luglio e ancora tra il 30 agosto e il 2 settembre 2017, una serie di incendi ha devastato il cratere. Le fiamme hanno percorso oltre 150 ettari, più del 60% della superficie, bruciando la vegetazione del sottobosco, danneggiando le chiome di interi popolamenti di leccio, e distruggendo la rinnovazione arborea in vaste aree. Il fondo del cratere ha subito danni anche al suolo, con combustione della lettiera e delle radici.
Poi, nel 2022, un nuovo incendio doloso ha bruciato 40 ettari, di cui 8 all’interno della Riserva. Il 90% degli alberi colpiti è risultato morto o gravemente indebolito. E dove il fuoco ha aperto varchi, sono arrivate specie aliene invasive come robinia e ailanto, che mettono a rischio il recupero della foresta originaria.
Da queste ferite nasce ABCD – Astroni Bosco da Conoscere per Difendere, un progetto che punta non solo al ripristino ecologico, ma anche alla partecipazione attiva della comunità locale. Tutti gli incendi registrati in passato sono partiti fuori dai confini della Riserva, spesso in aree agricole, aree urbane incolte o discariche abusive. Coinvolgere chi vive lì accanto, costruire consapevolezza, attivare reti civiche di sorveglianza e cura: è questa l’unica vera prevenzione. Il bosco non si protegge da solo. Va protetto insieme.

Oasi WWF Astroni, Napoli
Pianificare per conoscere, gestire, proteggere
Non si può curare una foresta se non la si osserva nel tempo, con metodo, pazienza, rigore. È proprio questo il compito di un piano di assestamento forestale: uno strumento tecnico e operativo, decennale, che descrive lo stato di salute del bosco, ne analizza struttura e dinamiche, valuta i rischi e pianifica gli interventi per garantire conservazione, sicurezza, accessibilità e — dove compatibile — anche produzione sostenibile.
In Italia, però, meno della metà dei boschi pubblici è oggi coperta da un piano di gestione aggiornato. Nei boschi privati la percentuale è ancora più bassa. Eppure la Strategia Forestale Nazionale, approvata nel 2022, indica tra i suoi obiettivi prioritari proprio l’aumento della superficie pianificata, anche come condizione per accedere ai finanziamenti europei.
Il Piano di Gestione Forestale 2020–2029 della Riserva degli Astroni è il primo nella sua storia. Redatto da un team di agronomi e forestali su incarico del WWF, non ha finalità produttive. Serve a proteggere le persone e la biodiversità. Mette in sicurezza i sentieri, monitora gli alberi a rischio caduta, rimuove le specie aliene invasive, risana le infrastrutture storiche, mantiene le radure e le zone umide. Il tutto secondo tecniche a basso impatto, come l’ingegneria naturalistica e la regimentazione dolce delle acque.
Il piano suddivide il territorio in due grandi comprese:
- la Compresa A, in fondovalle, è destinata alla conservazione ecologica e alla fruizione didattica e scientifica. Comprende fustaie miste di farnia, carpino, quercia rossa, pino domestico, boschi ripariali e aree palustri;
- la Compresa B, sui versanti più ripidi, ha una funzione prevalentemente protettiva e idrogeologica. Vi crescono fustaie transitorie di leccio, castagno e carpino nero, con tratti di macchia mediterranea e vegetazione arbustiva.
Prevenzione: la chiave è il fuoco
Un intero capitolo del piano — il 10.1 — è dedicato alla lotta agli incendi boschivi. Tra le azioni previste ci sono:
- la riduzione selettiva della biomassa lungo i sentieri e le aree critiche;
- la realizzazione di torri di avvistamento e di un sistema di videosorveglianza termica a energia solare;
- e, soprattutto, l’impiego sperimentale del fuoco prescritto.
Il fuoco prescritto consiste nel bruciare in modo controllato e sotto condizioni meteorologiche precise una porzione selezionata di sottobosco, in modo da ridurre il carico di combustibile fine, favorire la rinnovazione di alcune specie pioniere e prevenire incendi di più grande intensità. Se ben applicata, questa pratica può rafforzare la resilienza ecologica del bosco, aumentando la sua capacità di assorbire e “rallentare” il fuoco, invece che alimentarlo.
Il Cratere degli Astroni è un laboratorio a cielo aperto di ecologia urbana, dove si sperimentano soluzioni forestali innovative in uno dei contesti più complessi d’Italia: un polmone verde chiuso tra quartieri densamente popolati, ex aree industriali, discariche, tangenziali. Non è solo un luogo da visitare. È un messaggio da ascoltare.
Tappa 7: Castel di Sangro – Tagliacozzo
Gole del Sagittario: dove l’acqua scolpisce la foresta
All’uscita dello sprint di Sulmona, la strada del Giro risale verso le montagne. Ma se si devia a sud-est per 15 km, si entra in un paesaggio verticale, scavato dal tempo e dall’acqua: le Gole del Sagittario, uno dei canyon più spettacolari dell’Appennino centrale. Qui, tra pareti calcaree alte centinaia di metri e boschi che risalgono le valli come vene verdi, l’Oasi WWF e Riserva Naturale Regionale custodisce 450 ettari di biodiversità estrema. Siamo nel cuore del sistema delle aree protette abruzzesi, al crocevia tra il Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Sirente Velino. Le Gole, oltre ad essere Zona Speciale di Conservazione (cod. IT7110099), sono anche zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo. Una posizione strategica per la connettività ecologica dell’Appennino centrale.

Gola del Saggittario, Sulmona
Foreste tra le rocce: tre habitat da conservare
Nonostante la superficie contenuta, la Riserva ospita una varietà eccezionale di ambienti forestali, in gran parte protetti dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea, che ha istituito il network Natura 2000 per tutelare gli ecosistemi più fragili e rappresentativi. Ogni sei anni, lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario deve essere valutato con indicatori nazionali specifici: estensione, struttura, funzione ecologica, pressioni, tendenze.
Nel caso delle Gole del Sagittario, i tre principali habitat forestali sono:
- Habitat 92A0 – Foreste a galleria di Salice bianco e Pioppo bianco: boschi ripariali che si sviluppano lungo il fiume Sagittario e le sue sorgenti, frammentari ma vitali per la biodiversità acquatica. Qui crescono salici bianchi, pioppi neri e bianchi, formazioni tipiche dei fondovalle mediterranei umidi.
- Habitat 9340 – Leccete montane: boschi sempreverdi che si annidano tra le falesie e i ghiaioni calcarei, spesso con portamento arbustivo. Nuclei di leccio spuntano tra le rocce, in condizioni estreme, formando microhabitat preziosi per insetti, uccelli rupicoli e rettili.
- Habitat 9180* – Boschi di forra del Tilio-Acerion: foreste mesofile e umide, ricche di aceri, frassini, olmi, tigli, tassi, che si sviluppano in forre fresche e umide, dove la roccia affiora tra muschi, felci e lettiere profonde. Un habitat raro nell’Appennino, con valenze paesaggistiche e naturalistiche altissime.
Oltre a questi, la Riserva ospita faggete in quota, boschi misti di latifoglie, rimboschimenti di conifere degli anni ’50 oggi a rischio incendio per mancanza di gestione, e praterie secondarie in progressione ecologica. Le foreste, qui, non sono solo cornice ma protagoniste: risalgono i versanti, filtrano le acque, stabilizzano i suoli. Sono ciò che tiene insieme paesaggio, suolo e vita.

Gola del Saggittario, Sulmona
L’acqua, la vita e il compromesso
La ricchezza animale e vegetale di questo luogo — orso bruno marsicano, lupo appenninico, aquila reale, lepre italica, lontra, trota macrostigma — esiste grazie a una sola cosa: l’acqua del fiume Sagittario. Un’acqua fredda, limpida, irrequieta. Ma non sempre è stato così. Qualche decennio fa, la costruzione di una diga a scopo idroelettrico ridusse il fiume a un letto secco. La vita scomparve. Fu un guasto tecnico all’impianto a restituire il flusso. E bastò poco: tornò l’acqua, tornò la vita. Allora, gli abitanti di Anversa degli Abruzzi — che avevano visto il Sagittario muto per anni — si mobilitarono per non perderlo un’altra volta. La trattativa tra la Riserva e il gestore della diga portò a un compromesso: il rilascio costante di un deflusso minimo vitale lungo tutto il corso. Da allora, il Sagittario canta di nuovo. E gli anziani del paese ricordano il giorno in cui il fiume tornò a parlare come nella loro infanzia.
È una storia esemplare. Perché ci ricorda che anche l’energia “pulita” ha un costo ecologico, se non è gestita con attenzione. E che una gestione intelligente delle risorse — acqua, suolo, foresta — è possibile, se guidata dalla conoscenza e dal confronto.
Le foreste che proteggono l’acqua
Non c’è fiume senza foresta. Le foreste riparie assorbono i nutrienti in eccesso, filtrano i sedimenti, mantengono l’acqua fresca e ossigenata, impedendo il riscaldamento estivo dei torrenti. Quelle di versante regolano i deflussi, migliorano l’infiltrazione, limitano il ruscellamento e quindi proteggono la qualità e la quantità delle risorse idriche. Nelle Gole del Sagittario, questo legame è evidente: dove ci sono boschi di fondovalle e forra, l’acqua scorre più limpida, i suoli sono più stabili, la biodiversità esplode. Ma se la vegetazione manca, l’erosione avanza e il rischio idrogeologico aumenta.
Gestire bene le foreste significa proteggere l’acqua, il suolo, la vita. E anche l’economia locale, fatta di turismo dolce, prodotti tipici e orgoglio territoriale. Non a caso, la Riserva promuove educazione ambientale, corsi di riconoscimento delle piante, agricoltura naturale e turismo sostenibile, dimostrando che anche una piccola oasi può avere un impatto enorme sul futuro delle montagne.
E ora, appuntamento alla seconda settimana: mentre il Giro sale verso l’Appennino settentrionale e le Prealpi, continueremo il nostro viaggio nelle foreste italiane. Tra gli highlight, la Tappa 10 con il Bosco di Cornacchiaia e il Bosco del Bottaccio, e la Tappa 12, che ci porterà nella Riserva Naturale delle Bine, tra Lombardia e Mantova. Tre boschi diversi, tre nuove occasioni per raccontare la scienza e la gestione che li custodiscono.
Perché conoscere le nostre foreste è il primo passo per proteggerle.
Info Autori
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)
Università degli Studi di Milano